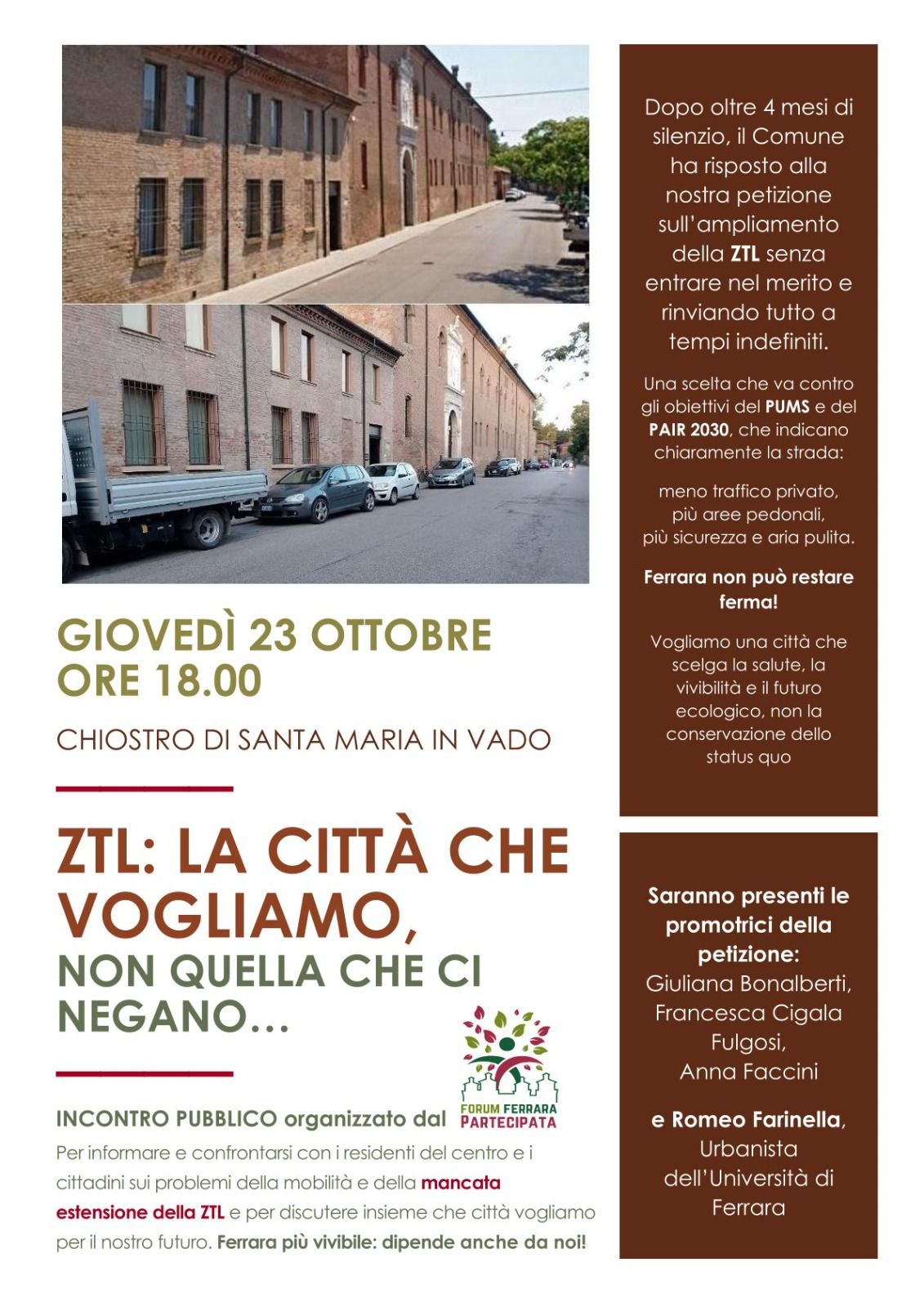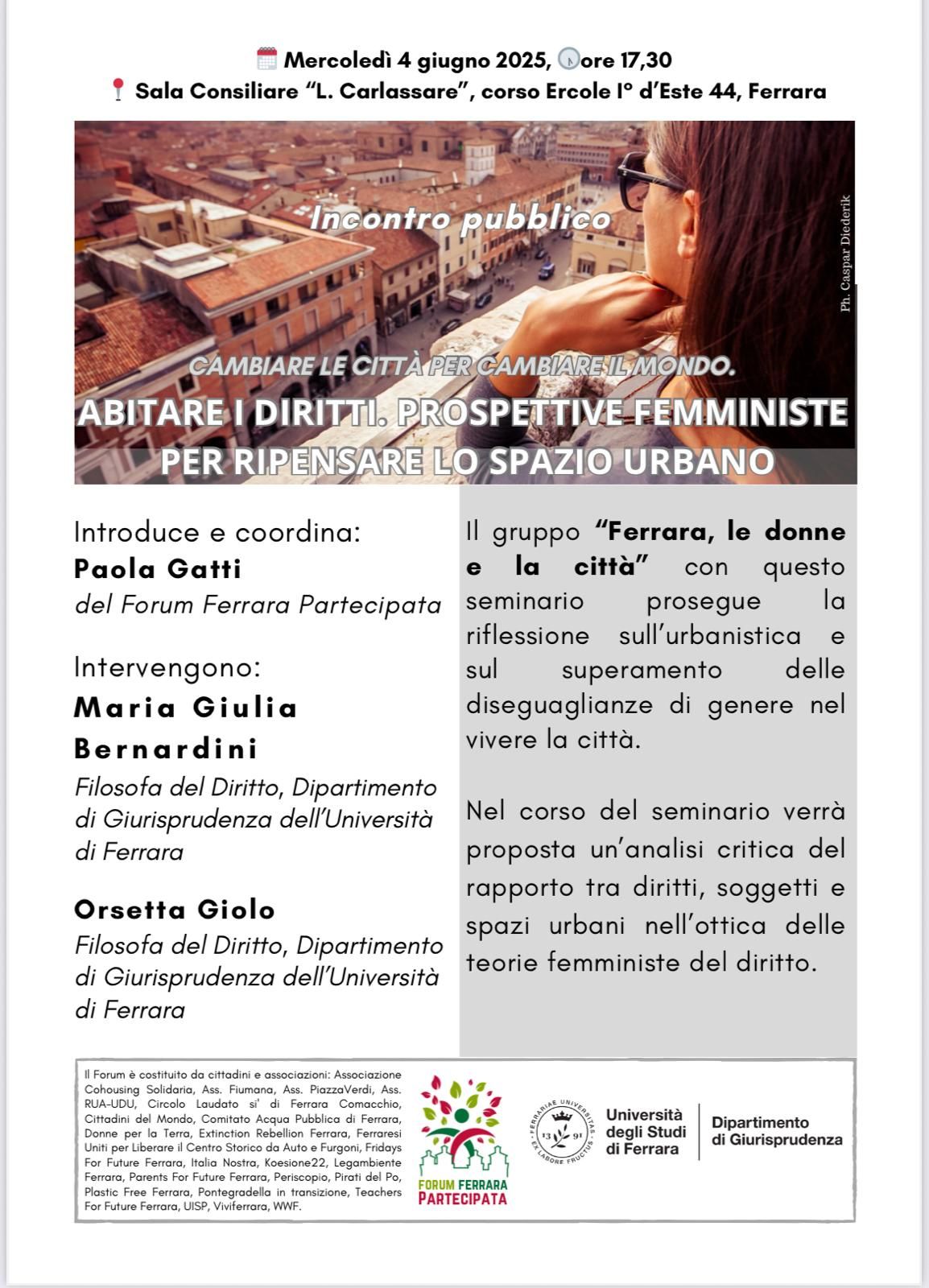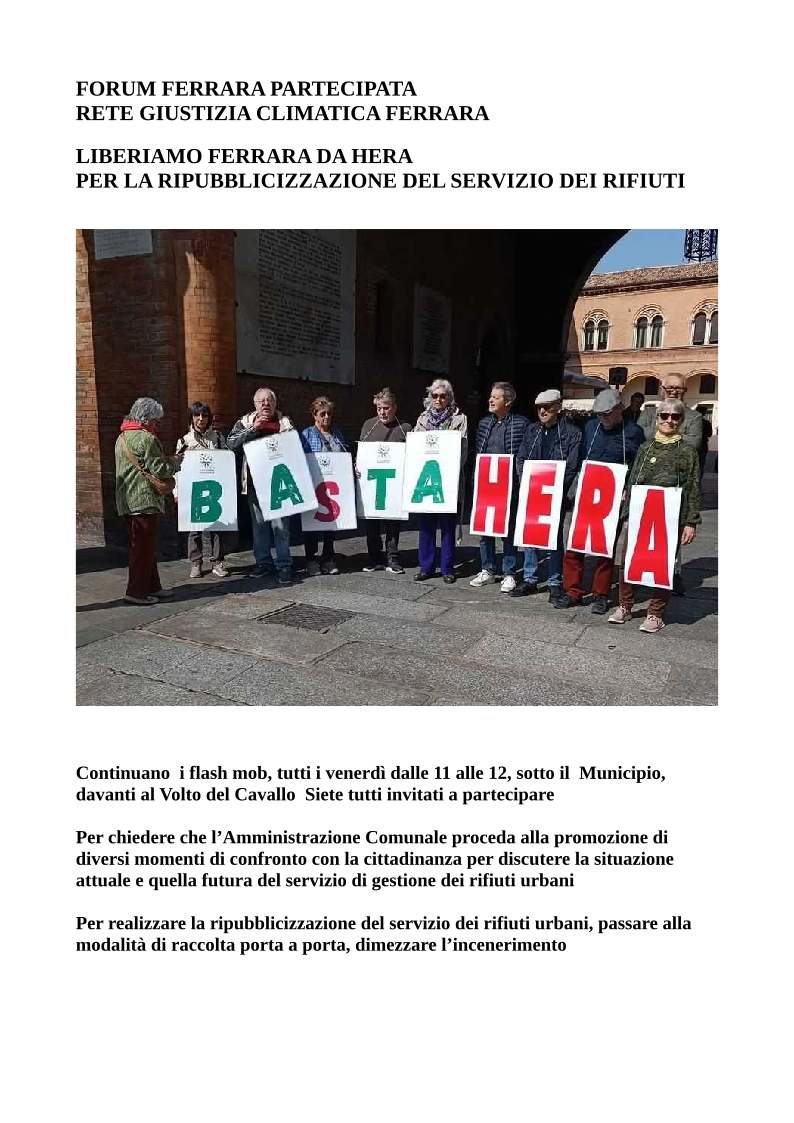WOMEN’S WISE WORKSHOPS “DAL VIVERE GLI SPAZI AL PROGETTARE I LUOGHI” PROGETTO PARTECIPATIVO WWW. ATTRAVERSARE CONOSCERE COPROGETTARE
Leggi file PDF
Responsabile scientifico: Letizia Carrera, docente di Sociologia del territorio presso l’Università di
Bari, coordinatrice del Laboratorio di Studi Urbani URBALAB
Il progetto di ricerca è stato promosso dal gruppo “Ferrara, le donne e la città” al fine di sollecitare
una nuova consapevolezza dei bisogni e dei diritti delle donne nell’esperienza urbana, mettere in luce
le difficoltà e i problemi che le donne affrontano nella vita quotidiana riguardo alla mobilità, alla
sicurezza, ai servizi, agli spazi di relazione, ripensare in concreto gli spazi della città, le periferie, la
mobilità, la cura dell’ambiente urbano attraverso il confronto con le esigenze e le esperienze di vita
vissuta per giungere a possibili proposte di interventi sulla città.
Attraverso esperienze di laboratori urbani e di riflessione collettiva, le partecipanti al processo di
ricerca-azione hanno esplorato lo spazio urbano, condividendo percezioni, bisogni e proposte per
rendere la città più inclusiva e attenta alle esigenze delle donne.
I risultati vengono resi pubblici e presentati agli Amministratori con l’auspicio di contribuire a creare,
in prospettiva, le condizioni per una migliore qualità della vita delle donne e degli altri attori urbani
nella città.
“La città accogliente e friendly per le donne è una città che sa tendere all’obiettivo di essere inclusiva,
sostenibile e people friendly”.
Il laboratorio WWW trova la sua matrice teorica nel principio del “diritto alla città” tematizzato dal
filosofo francese Henri Lefebvre e che si declina sia come diritto a vivere pienamente la città, sia come
diritto a partecipare alla sua progettazione.
Questa teorizzazione è il fondamento dei principi di democrazia territoriale – il diritto a una città di
qualità a prescindere dallo specifico luogo di residenza andando oltre il limite della città “spezzata” tra
centro e periferie -, e di quello di giustizia sociale – diritto a poter fruire delle opportunità e dei servizi
messi a disposizione dalla città a prescindere dalla specifica dotazione individuale di risorse
economiche, culturali e sociali. Il richiamo evidente è alla teoria della capabilities di Amartya Sen e
Martha Nussbaum che ritiene imprescindibile centrare l’attenzione sulle reali opportunità fruibili dai
soggetti (opportunities) più che sulla loro mera presenza nello spazio urbano
PREMESSA
Le città sono storicamente progettate secondo un immaginario maschile, che spesso ignora i bisogni e
le esperienze quotidiane delle donne. L’adozione del “gender mainstreaming” nella pianificazione
urbana può permettere di superare alcuni limiti di questo approccio, favorendo un accesso equo ai
servizi e una maggiore partecipazione ai processi decisionali.
“Le donne vivono ancora la città con una serie di barriere fisiche, sociali, economiche e simboliche
che condizionano la loro vita quotidiana” ( Leslie Kern 2019), ma è proprio a partire da questi ostacoli
che proprio loro possono generare una nuova visione urbana: più sensibile, più umana, più
sostenibile.
Le città infatti non sono neutre. Sono state progettate da urbanisti maschi per soddisfare modelli
maschili di vita centrati sul lavoro produttivo, su spostamenti lineari, su tempi rigidi, su strutture
pensate per un uomo adulto, sano, motorizzato. Ma la vita reale, quotidiana, è ben più complessa e a
pagarne il prezzo sono soprattutto le donne, con le loro giornate frammentate tra lavoro, cura,
spostamenti multipli, carichi familiari.
Da queste analisi discende la seconda declinazione del diritto alla città a cui si è fatto riferimento, che
richiama in modo stringente la necessità che gli amministratori e i progettisti dialoghino in modo
continuo e sostanziale con i cittadini e, naturalmente con le cittadine, riconosciuti quali portatori di
specifiche competenze e di un sapere connesso alla pratiche quotidiane
Molte città hanno già iniziato a integrare la parità di genere nelle politiche urbanistiche, sociali e
culturali: a Vienna, a Barcellona, ad Amsterdam, a Bilbao si sono realizzati interventi che,
soddisfacendo i bisogni e i diritti delle donne, hanno contribuito ad attivare processi di uguaglianza dei
diritti e percorsi di transizione ecologica.
Per il cambiamento è necessaria un approccio sistemico abbandonando una visione unicamente
economica del mondo per assumere una visione ecologica, in grado di collegare le complesse
dinamiche della vita quotidiana con la tutela dei beni comuni ( aria, acqua, suolo) e la garanzia dei
servizi ai cittadini ( educazione, sanità, trasporti ). Le donne, per la loro esperienza di vita, sono
portatrici di una visione sistemica, complessa, capace di tenere insieme tempi, relazioni, spazi e
necessità. Oggi più che mai è di questa complessità che abbiamo bisogno.
“Le donne possono dare un contributo determinante a immaginare un nuovo modello di convivenza
urbana, con la forza delle loro idee, con i loro bisogni e desideri, mettendo a nudo quello che non
funziona e che potrebbe cambiare, rivelando le asimmetrie nella ripartizione del potere e delle
responsabilità”( Elena Granata 2023 ).
Da queste premesse deriva l’urgenza di iniziare ad elaborare, con la partecipazione diretta delle
donne e sulla base dell’analisi dei loro bisogni, proposte concrete di modifica della città da sottoporre
agli Amministratori. Proposte che parlino di trasporti più accessibili, di spazi pubblici sicuri e
accoglienti, di orari urbani compatibili con la vita reale, di servizi di prossimità.
OBIETTIVI
• Rilevare le percezioni femminili dello spazio e delle sue pratiche d’uso: comprendere come le
donne vivono e percepiscono gli spazi urbani, identificando aree che favoriscono o ostacolano
la loro mobilità e sicurezza. “Spazi e luoghi gender friendly per progettare città people
friendly”.
• Promuovere l’empowerment sociale e politico: incoraggiare le donne a diventare agenti attive
nel processo di progettazione urbana, fornendo loro strumenti per rilevare esigenze e bisogni
ed esprimere proposte.
• Influenzare le politiche urbane: utilizzare i dati raccolti durante i laboratori urbani per avviare
un dialogo con le amministrazioni territoriali e proporre soluzioni concrete di
infrastrutturazione urbana per garantire una maggiore inclusività e attenzione alle esigenze di
genere.
METODOLOGIA
Poiché l’intento prioritario era dare voce alle donne della città, si è adottato il consolidato metodo
della ricerca sociologica qualitativa che consente di esplorare fenomeni sociali complessi e di acquisire
comprensione delle dinamiche sociali, tramite il punto di vista dei soggetti e il significato che essi
attribuiscono alle loro esperienze.
QUI un testo esplicativo di Letizia Carrera, docente che ha curato la ricerca.
DAL «progettare per» AL «progettare con»
Il progetto Women’s Wise Walkshops è centrato sulla premessa di riconoscere la competenza delle
cittadine e dei cittadini che abitano i luoghi. È fondato su un processo partecipativo complesso che
persegue un duplice obiettivo: ascoltare, dare struttura e amplificare le voci di chi abita la città e
promuovere il coinvolgimento civico e la connessione tra attori sociali diversi al fine di una
progettazione urbana partecipata.
FASI e STRUTTURA del progetto e impianto delle attività di ricerca-azione
1. Identificazione, in collaborazione con associazioni locali e gruppi organizzati del territorio, di
donne che presentino tratti sociali differenziati in una logica intersezionale.
2. Conduzione di interviste semi-strutturate con le donne residenti nei quartieri selezionati
come riferimento territoriale per i laboratori urbani.
3. Organizzazione di focus group basati sui risultati iniziali emersi dai protocolli di intervista e
misurazione degli iniziali investimenti individuali sulle pratiche partecipative.
4. Implementazione di walkshop urbani, progettati sulla base del modello delle dérive
situazioniste, ma con una maggiore declinazione sociale, che coinvolgano donne di diverse
età e background sociali.
5. Creazione di mappe tematiche basate su metodologie partecipative e rivalutazione del livello
di engagement delle cittadine coinvolte nei diversi percorsi.
6. Sviluppo di un documento condiviso che sintetizzi le osservazioni e i rilievi raccolti dalle tre
fasi precedenti, delineando infine una serie di raccomandazioni di politiche urbane e
interventi concreti per gli spazi urbani.
7. Realizzazione di tavoli di confronto con la cittadinanza e con gli amministratori locali, sulla
base dei dati emersi per un dialogo e una riflessione condivisa sui risultati per l’elaborazione
di specifiche politiche urbane.
Fasi di realizzazione della ricerca
• Individuazione di due quartieri, uno centrale e uno periferico, diversi per caratteristiche e
problematicità in cui svolgere la ricerca: quartiere Arianuova-Giardino e quartiere Krasnodar.
• Realizzazione di 65 interviste semistrutturate e realizzate in presenza rivolte a un campione di
donne dei due quartieri diverse per estrazione socio-culturale, lavorativa ed età. Fasce di età
18/35, 36/65, over 65. Interviste semistrutturate finalizzate alla raccolta di dati relativi a
comportamenti, valutazioni, rappresentazioni dello spazio urbano e delle pratiche quotidiane,
e di proposte per il miglioramento della qualità della vita del territorio.
• Realizzazione di 2 focus groups: uno per quartiere, coinvolte complessivamente 25 residenti,
diverse per estrazione socio-culturale, lavorativa ed età. Discussione di gruppo, a partire dai
macrotemi emersi dall’elaborazione e dell’analisi delle interviste condotte nella fase
precedente, finalizzata a raccogliere esperienze, idee, riflessioni, proposte delle partecipanti
sui diversi temi urbani.
• Realizzazione di 2 walkshops: uno per quartiere, coinvolte complessivamente 26 residenti,
diverse per estrazione socio-culturale, lavorativa ed età. Laboratori urbani organizzati in due
diverse fasi: a) realizzazione di camminate osservazionali (dérive) attraverso i luoghi urbani
individuati come oggetto della riflessione condivisa con lavoro individuale: ogni partecipante
osserva, riflette e prende appunti. b) Confronto sul tema individuato e sulle osservazioni
ottenute, all’interno di uno spazio chiuso.
• Realizzazione di 2 incontri, uno per quartiere, con tutte le partecipanti al focus group e al
laboratorio urbano, per la discussione di gruppo sui materiali emersi dal lavoro complessivo
trattati con il metodo delle Word Clouds per l’analisi del contenuto e con quello dell’analisi
tematica.
• Elaborazione di un documento condiviso che avanzi ipotesi di (ri)progettazione dello spazio
urbano inteso quale elemento materiale e immateriale;
• Realizzazione di un evento pubblico nel quale sono stati presentati e discussi i risultati emersi
dall’analisi dei materiali esito del percorso di ricerca.
I risultati emersi dal laboratorio WWW Ferrara mostrano con nettezza le potenzialità di questo
metodo di indagine sociale in grado sia di cogliere dimensioni e rappresentazioni sottostanti i
comportamenti e sia di mettere a valore un sapere pratico e quotidiano di esperibilità dei luoghi.
Premessa necessaria dalla quale non si può prescindere è il riconoscimento di elevati livelli di fiducia
nutrito dai cittadini nei confronti dell’amministrazione e la convinzione di essere parte di un percorso
condiviso e sinergico per implementare nuovi progetti per migliorare l’infrastrutturazione materiale e
immateriale dello spazio e quindi garantirne una maggiore vivibilità per tutti i diversi tipi di cittadini.
I dati emersi, al pari di quelli generati dalle altre esperienze metodologiche, non vanno quindi
interpretati come sterili critiche rivolte all’amministrazione, quanto, invece, come un percorso
partecipato di ripensamento e di miglioramento degli elementi materiali e immateriali della città per
aumentarne il livello di vivibilità.
RISULTATI
Per risultati si intendono le proposte operative emerse dal lavoro di ricerca al fine di riprogettare la
città secondo una prospettiva di genere, per una città a misura di tutti i suoi abitanti: “una mappatura
sociale per policy urbane di città gender/people friendly”.
Proposte sintetizzate esposte per aree tematiche
Mobilità
• Pianificazione di una mobilità dolce, sicura e intermodale che si confronti con i tragitti
complessi e frammentati spesso compiuti dalle donne ( lavoro, accompagnamento figli,
acquisti, cura di persone anziane).
• Rafforzamento della rete pedonale e ciclabile, migliorando l’illuminazione, la visibilità e la
sicurezza (anche quella percepita).
• Progettazione e implementazione del trasporto pubblico con attenzione a frequenza, orari
serali, segnaletica accessibile, sicurezza alle fermate e veicoli facilmente accessibili.
• Predisposizione di parcheggi di scambio e navette elettriche di collegamento (park & ride).
• Diminuzione del costo del biglietto del bus o estensione della durata della validità.
Spazi pubblici
• Adeguamento strutturale degli spazi pubblici per l’accesso di soggetti con disabilità
permanente e temporanea.
• Riprogettazione degli spazi pubblici con una maggiore infrastrutturazione materiale e
immateriale adeguata alla fruizione differenziata dei luoghi: più panchine, più bagni pubblici,
più illuminazione, marciapiedi più larghi e ben manutenuti, rimozione barriere
architettoniche.
• Creazione di spazi verdi diffusi e migliore cura del verde esistente.
Sicurezza
• Applicazione del principio di “prevenzione ambientale del crimine” (CPTED) con criteri di
progettazione orientati alla sicurezza: visibilità, presenza umana, illuminazione, assenza di
barriere visive.
• Contrasto dell’abbandono e della marginalità degli spazi pubblici tramite l’attivazione sociale
e culturale sostenuta dall’amministrazione pubblica e da una rete multiattoriale.
• Collaborazione con centri antiviolenza, associazioni e comitati per mappare aree a rischio e
progettare interventi mirati.
• Sostegno agli esercizi commerciali di prossimità come presidi di presenza di vitalità della zona
e presidio di sicurezza.
Servizi per i cittadini
• Progettazione della città in funzione dei tempi di vita e di lavoro delle persone, promuovendo
la “città dei 15 minuti” che consenta di accedere a servizi essenziali (scuole, centri di medicina
territoriale, commercio, verde pubblico) in prossimità dell’abitazione.
• Potenziamento dei servizi di prossimità (nidi, centri anziani, consultori, sportelli sociali, …)
accessibili a tutte le fasce della popolazione.
• Creazione di spazi pubblici flessibili, multifunzionali e intergenerazionali che incentivino la
socialità e un nuovo modello di cura e di responsabilità sociale condivisa.
• Investimento sugli esercizi commerciali di prossimità da considerare non solo come valore
economico ma anche per il loro ruolo di veri presidi civici.
Spazi associativi
• Censimento e riqualificazione di edifici e spazi, in modo diffuso nella città, per garantire luoghi
pubblici di incontro (anche al chiuso).
• Biblioteche, cinema, palestre diffuse per creare occasioni di consumi culturali e di socialità.
• Predisposizione di piani sociali (co-progettati) per aumentare il senso di sicurezza percepito
dagli abitanti e consentite di fruire di queste possibilità anche la sera.
• Case di quartiere (vedi https://www.retecasedelquartiere.org/cos-e-la-rete-delle-case/).
Partecipazione
• Attivazione di processi partecipativi che includano donne, giovani, anziani, persone con
disabilità, caregiver e altri gruppi sottorappresentati nei processi decisionali, con
un’attenzione anche alle diverse etnie presenti nella città.
• Utilizzo di metodologie di ricerca-azione come i “gender walk” (camminate esplorative di
genere),le mappe partecipate e i laboratori di quartiere per raccogliere dati qualitativi sull’
esperienza urbana, da combinare con quelli statistico-demografici.
• Favorire la presenza paritaria di donne e uomini nei tavoli decisionali per la progettazione
urbana e in quelli connessi alle politiche sociali territoriali.
• Favorire le associazioni e i comitati attraverso il finanziamento di una progettazione mirata
alla rigenerazione (materiale e immateriale) dello spazio urbano.
Lo strumento degli attraversamenti urbani, elemento innovativo rispetto alle attuali pratiche e ai
metodi di conoscenza dei luoghi su base partecipativa, si è confermato in grado di garantire, anche in
combinazioni con altre tecniche di indagine, una conoscenza approfondita e generativa dei territori in
vista della possibilità di percorsi collaborativi con le amministrazioni del territorio per una
riprogettazione e un miglioramento condivisi dello spazio urbano e delle forme dell’abitare.
Ferrara, le donne e la città
Ringrazia tutte le associazioni che hanno reso possibile questo lavoro partecipativo